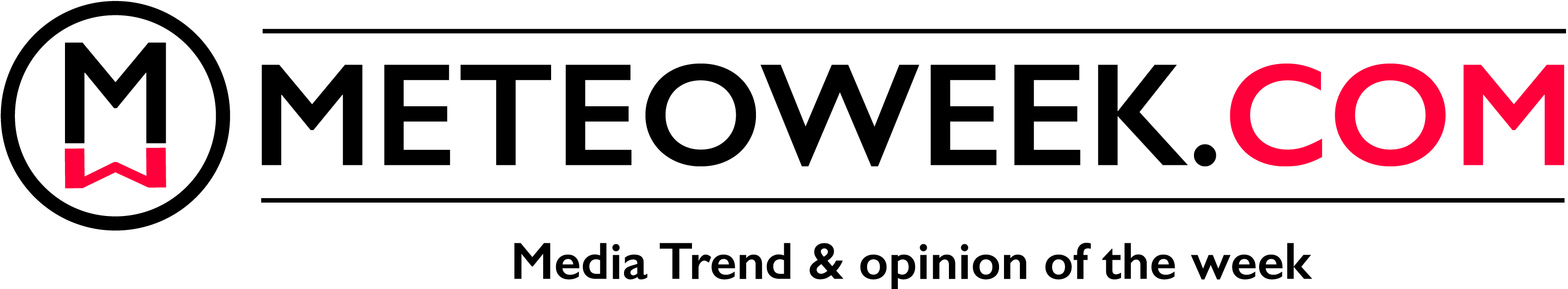Afghanistan: Trump attacca, ma la responsabilità del disastro è principalmente sua

Se ne parla poco, ma gli “Accordi di Doha”, con cui a fine febbraio del 2020 gli Stati Uniti di Trump stipularono la pace con i talebani, sono stati il riconoscimento ufficiale dei talebani come interlocutori politicamente legittimati.

Era il 29 febbraio 2020, il mondo (ed in particolare l’Europa) stava capendo che quel coronavirus proveniente dalla Cina sarebbe stato un problema enorme da gestire, e gli Stati Uniti di Trump stavano stipulando un accordo di pace con i talebani. Un evento storico, epocale che passò inosservato per la contingenza con lo scoppio della pandemia: ma se vogliamo comprendere quello che sta succedendo oggi in Afghanistan non possiamo ignorare quel che avvenne nella capitale del Quatar quel 29 febbraio.
LEGGI ANCHE: Come si comporteranno i sovranisti italiani davanti ai migranti afgani?
La firma degli accordi di Doha era stata preceduta da mesi di trattative, condotte per conto dell’amministrazione Trump da Zalmay Khalilzad, rappresentante speciale degli Stati Uniti. Sia la fase dei colloqui che poi quella finale della definizione degli accordi fu caratterizzata dall’assenza del governo afghano: la trattativa fu pensata e voluta da Trump come bilaterale. Da una parte gli Stati Uniti, dall’altra i talebani, nel reciproco riconoscimento di essere loro, i due principali contendenti di quella guerra. La firma apposta sull’accordo dal rappresentante degli Stati Uniti e dal mullah Abdul Ghani Baradar per i talebani, definì il ritiro delle truppe statunitensi dal territorio entro la fine di aprile del 2021. In cambio i talebani si impegnarono a rompere ogni forma di rapporto e anzi ad opporsi anche loro militarmente alle organizzazioni terroristiche come Al Quaeda e lo Stato Islamico (con cui effettivamente gli islamisti afghani si scontrarono, anche se probabilmente più per un discorso di egemonia interna).

Trump aveva bisogno di quel successo diplomatico per presentarsi più forte alle elezioni: ma i risultati sul medio termine sono stati tremendi. Escludendo il governo afghano del presidente Ghani l’amministrazione Usa lo indebolì terribilmente. Dall’altra parte invece riconobbe ufficialmente, formalmente e politicamente i talebani come legittimi interlocutori, rafforzandone incredibilmente la posizione. Una scelta che aveva senso nell’ottica di ottenere un risultato da utilizzare elettoralisticamente e sopratutto di mettere fine alla missione in Afghanistan, che dopo l’omicidio di Osama Bin Laden nel 2011 e sopratutto il mutare degli scenari globali aveva perso sempre più di importanza.
LEGGI ANCHE: Afghanistan, le sfide dell’Europa. Rashid: “Si prepari a grande crisi umanitaria”
Ma se vogliamo dare una definizione storica e politica a quello che stiamo vedendo in questi giorni dobbiamo tornare a quella data: 29 febbraio 2020. Il giorno in cui un presidente degli Stati Uniti riconobbe ufficialmente una entità della jihad islamica come interlocutore politico. Quando poi Biden ha vinto, e si è trovato di fronte questo accordo con le scadenze già definite, non ha fatto altro che cogliere la palla al balzo: la guerra in Afghanistan non è più un argomento che scalda il cuore degli americani, ed in tempi di recessione economica quei soldi possono essere spesi per altro. E dunque via al ritiro delle truppe: a quel punto il governo di Kabul, indebolito dalla scelta di Trump (che oggi attacca Biden, ma che sa perfettamente le cose come stanno) e privato dei suoi alleati sul campo, e cioè i paesi della Nato che avevano truppe schierate in Afghanistan, si è trovato ad affrontare un nemico che – a parte le dichiarazioni politiche “di circostanza” – non era in grado di affrontare. I talebani godono del sostegno di parte della popolazione, sono coesi, combattono da venti anni almeno e sono determinati: ed in più avevano anche il riconoscimento politico di Trump. Non poteva che andare a finire così.