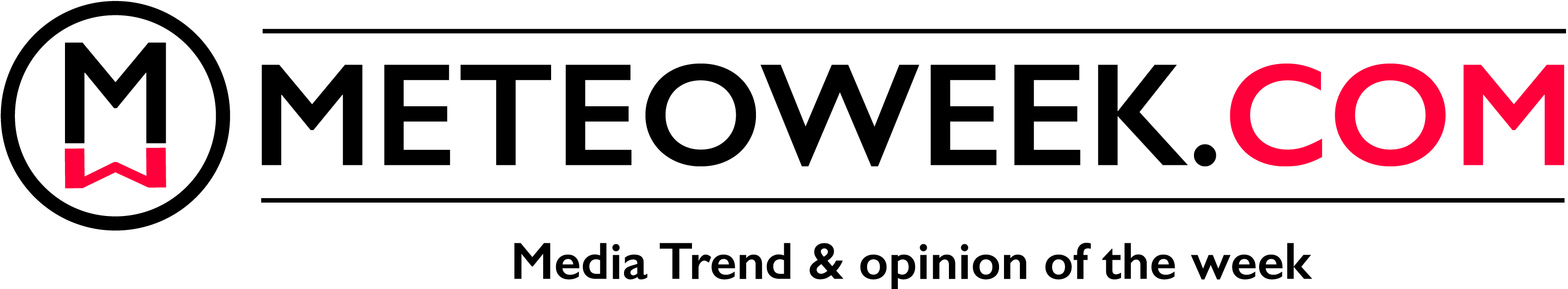Letta: “No partito del potere, serve un nuovo PD”. E’ sfida alla leadership dei dem

Parole scontate, forse, ma pesanti come un macigno quelle di Enrico Letta alla presentazione della sua candidatura – poi votata a stragrande maggioranza – a segretario del PD.

Dire all’attuale dirigenza del PD di lasciar perdere le dinamiche di potere, di non puntare per forza al governo, di cercare una sintesi politica interna per poi rivolgersi al di fuori (sinistra, M5S) è come chiedere ad un fumatore accanito di smetterla con le sigarette da un minuto all’altro. Paragone esagerato? Insomma: se si guarda alla storia dei Dem dalla loro fondazione ad oggi (era il 2007) le logiche di potere ed il correntismo sono state caratteristiche quasi costante del partito fondato, tra gli altri, dallo stesso Letta. La sua stessa nascita fu paradossale, perchè contribuì – non da sola, ovviamente – a far cadere il governo Prodi II, che è l’ultima esperienza vincente di una coalizione di centro sinistra. Da quel momento l’obiettivo politico del Partito Democratico è sembrato più quello di governare che di convincere l’elettorato. Dall’adesione al governo Monti a tutta la XXVII° legislatura (durante la quale il Pd era si il primo partito, ma la coalizione di centro sinistra era sostanzialmente in parità complessiva con quella si centro destra), fino al governo giallorosso di Giuseppe Conte e a quest’ultimo guidato da Mario Draghi, i Dem hanno praticamente sempre avuto ruoli di governo pur non risultando nettamente preferiti dall’elettorato.
Leggi anche: Oggi l’assemblea del PD: Letta segretario, ma lo aspetta un lavoro quasi impossibile
La democrazia parlamentare ha regole diverse da quelle della retorica e del facile consenso: tutti i governi a cui il Partito Democratico ha partecipato avevano senza dubbio piena legittimità costituzionale, anche in considerazione di leggi elettorali che difficilmente garantivano e garantiscano maggioranze solide e governabilità. Resta però evidente come, “pur” di governare, i Dem abbiano accettato intese politiche veramente dure da digerire per la base. Partendo da Silvio Berlusconi e arrivando al Movimento 5 Stelle. Ed ogni volta questo tipo di scelte erano sempre condite da un “per l’interesse del paese”, “per opporci alle destre”, “perchè ce lo chiede il presidente della Repubblica”. Giustificazioni anche legittime, per carità, che però sortivano l’effetto di diventare motore di scelte indirizzate a mantenere comunque una presenza nei governi. Perdendo però, inevitabilmente ed inesorabilmente, identità politica e capacità di persuasione dell’elettorato. Con risultati peraltro evidenti: nel 2013, ad esempio, appena usciti dal governo Monti (di cui era stato tra i sostenitori) il Pd ottenne un 25% circa. Dopo cinque anni di governo (Letta-Renzi-Gentiloni) e di alleanze curiose (Berlusconi, Alfano) alle urne ottenne poco più del 18%. Circa sette punti percentuali in meno.

Quella che poi si configurava come una legislazione all’opposizione, si è di nuovo trasformata in esperienza di governo. Il ribaltone che ha portato il governo “gialloverde” a diventare “giallorosso” fu opera in gran parte di Matteo Renzi, che già aveva dato prova di essere molto a suo agio all’interno delle dinamiche da retroscena politico: il patto del Nazareno, le maggioranze allargate, gli ammiccamenti al centro destra. Un metodo che forse ha premiato nel brevissimo termine, ma che ha generato un deterioramento del rapporto con l’elettorato. Non si può essere il partito buono per tutte le occasioni. I risultati recenti lo dimostrano: ma bastano per convincere della necessarietà di un cambiamento di rotta? Fino ad ora no.
Leggi anche: Letta apre al “M5s di Conte”. Ma Zingaretti non si era dimesso per questo?
Ma quando Letta sostiene la necessità di un partito lontano dalle logiche di potere, pronto anche a stare all’opposizione, che non esista per governare ma per proporre politica, afferma la necessità di una trasformazione enorme che non può non partire dalla classe dirigente. Che è esattamente la stessa da quindici anni, più o meno. E dunque, per logica, la prima cosa su cui Letta dovrebbe lavorare con forza è proprio il ridimensionamento dello strapotere delle “correnti”, dei leader, di qualche presidente di regione che pensa più al suo ruolo che alle dinamiche del partito. Ma è possibile senza lasciarci le penne, politicamente parlando? All’interno di un partito che ancora al suo interno ha una componente renziana, con Renzi che nel frattempo si è fatto un suo partito ed è fuori. E’ questo l’argomento, ma il timore è che il fatto stesso di affrontarlo possa generare le premesse per una seconda, grande delusione per Enrico Letta da parte del PD.