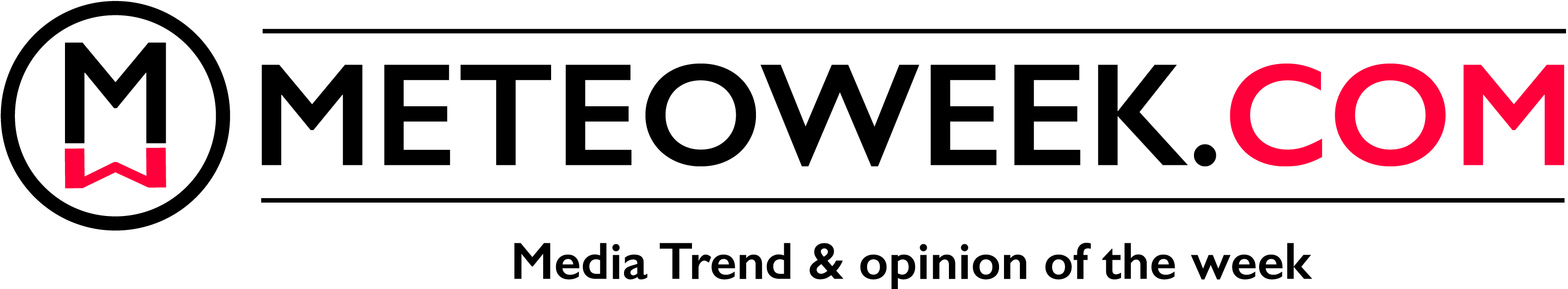25 novembre, come i media e le pubblicità ci abituano a una forma di violenza stereotipata

La violenza che vediamo in tv, nei film e nelle pubblicità è spesso distorta dalla sua reale origine, ben diversa dalle immagini.

Nei media mainstream, il discorso sulla violenza maschile contro le donne presenta costanti tematiche, estetiche e retoriche che assumono valenza universale. Una politica di rappresentazione universale sembra ispirare le serie Tv, i prodotti, le cronache, le narrazioni e, di conseguenza, anche i numerosi spot a scopo di sensibilizzazione sul tema. La violenza sulle donne, negli spot, è una forma di violenza stereotipata. Nello spot del 2012 – “1522 a sostegno delle donne vittime di violenza” – ad esempio, si rimanda ad una pratica sociale molto comune in chi subisce violenza: mentire e trovare scuse. Una donna sull’autobus, con l’occhio visibilmente livido, racconta di aver sbattuto contro una porta.
“La violenza sulle donne non ha scuse”, si legge al termine dello spot. Una frase che suggerisce un’azione di prevenzione e contrasto: agire, raccontare, non tacere e non mentire. Si ignora, però, che talvolta per spingere all’azione di denuncia ci vogliono ben altre circostanze che devono attivarsi: talvolta è proprio il contesto ad impedire l’azione di denuncia; qualche altra le donne raccontano, ma non vengono credute.
Leggi anche:
- 25 novembre, con la pandemia più vittime di femminicidio. Ma pochissime denunce
- Niente lockdown per la violenza sulle donne: il Coronavirus moltiplica le richieste di aiuto
Elemento comune in tutti gli spot italiani, però, è quello di spingere le donne a rivolgersi alle autorità, partendo proprio dall’assunto che le istituzioni siano lì, pronte a risolvere il problema. Ipotesi tristemente smentita dai numerosi tentativi di denuncia andati a vuoto, dalle lunghissime pratiche burocratiche che bloccano le denunce, dall’impossibilità talvolta di agire con pene e restrizioni a causa della mancata accertazione del fatto.
“Chiama il 113 prima che sia troppo tardi”, recita ad esempio lo spot della Polizia di Stato del 2009. Uno stereotipo che si sfalda di fronte all’analisi psicologica delle “vittime”, la cui più grande frustrazione è proprio quella di non sentirsi vittime e che, dinanzi agli inviti a chiamare e a chiedere aiuto, alimentano la transizione della stessa donna da vittima a colpevole. E lo abbiamo visto, ad esempio, nel caso Genovese.
La forza delle immagini
Anche le immagini mostrate e rimostrate mostrano la violenza nell’unica forma visibilmente mostrata dai media. Un occhio nero, donne semplici, dallo sguardo triste, spintoni, uso della forza, infine la morte. Ciò determina che la violenza coincide con quella forma, talvolta quella più eccessiva; ma si ignora la violenza che non si vede. È come se bisognasse raggiungere un limite, una soglia, per potersi identificare come vittime. Chi subisce anche solo uno schiaffo dubita se identificarsi in quella categoria di donne: perché non si riconosce in ciò che la sfera mediale mostra e dimostra.
Dubita se uno schiaffo sia o no violenza: perché nei numerosi spot che spingono all’azione si mostra il peggio che può accadere e quando quel peggio non è arrivato si pensa di essere lontani da quel punto, lontani da quel limite, ci si sente protetti. “Io non sono lei”: la negazione è la forma più disperata di sofferenza che però viene – almeno nel contesto italiano – troppo spesso celato. La violenza negli spot, insomma, non è una violenza a 360 gradi, ma parcellizzata.
I ruoli sono ben distinti in vittime, carnefici, istituzioni come risoluzione al problema. Così come è vero, dalla parte opposta, che anche il colpevole – anche qui, uso stereotipato dei ruoli – è solo così e solo in un modo. La violenza si allinea alla forza, all’aggressività, alla bestialità.

E certamente lo è, ma ci sono anche “altri uomini”; ci sono uomini che piangono dopo il gesto, che non stringono i pugni, che vivono anche loro una sofferenza nascosta che fuoriesce in modalità chiaramente inaccettabile. Sono sfaccettature, insomma – così come è vero che la violenza psicologica è meno rappresentata di quella fisica – che però non vengono mostrate in una narrazione mediale cristallizzata, fortemente focalizzata su pochi aspetti.
Sono queste solo alcune delle immagini della maschilità e della femminilità che gli spot chiamano in causa e che chiaramente non legittimano azioni di violenza, ma deresponsabilizzano quasi le autorità che invece – la storia insegna – talvolta possono essere responsabili non della violenza, ma della sua mancata risoluzione.