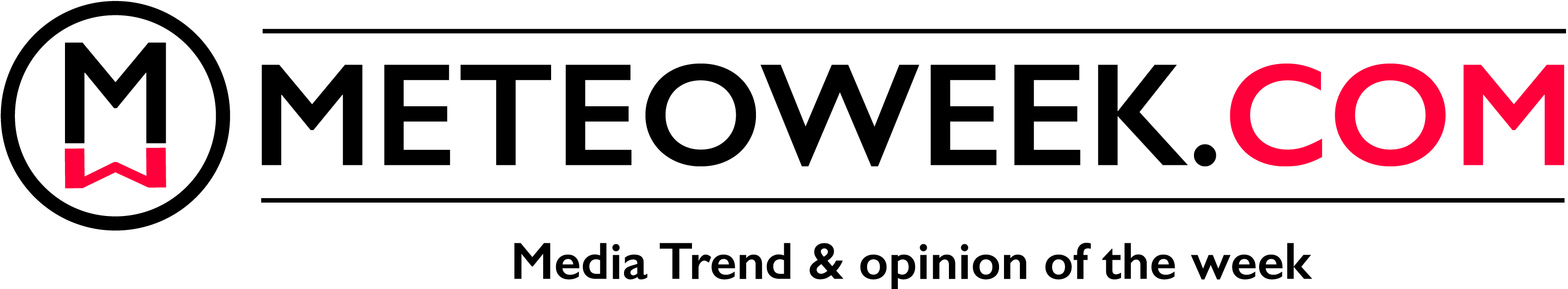Uccisione Floyd: un viaggio nell’epicentro delle proteste

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - MAY 28: Protesters stand in front of the 3rd precinct police building as it burns during a protest on May 28, 2020 in Minneapolis, Minnesota. Today marks the third day of ongoing protests after the police killing of George Floyd. Four Minneapolis police officers have been fired after a video taken by a bystander was posted on social media showing Floyd's neck being pinned to the ground by an officer as he repeatedly said, "I can’t breathe". Floyd was later pronounced dead while in police custody after being transported to Hennepin County Medical Center. (Photo by Scott Olson/Getty Images)
Il 25 maggio a Minneapolis veniva ucciso Floyd. Da quel giorno la città è sotto i riflettori della cronoca mondiale. Ma che clima si respira Minneapolis?

Minneapolis è la città che più spesso è stata nominata dalle cronache mondiali nei giorni scorsi. E’ normale: la città USA sulla sponda del Mississippi è l’epicentro delle proteste che stanno dilaniando l’America. Proprio a Minneapolis è avvenuto il tragico fatto che ha portato in piazza milioni di manifestanti. L’afroamericano George Floyd aveva 46 anni quando il poliziotto Derek Chauvin lo ha ucciso. Lo ha atterrato sebbene fosse disarmato e gli ha premuto un ginocchio sulla gola fino a soffocarlo. “I can’t breath” è la frase che oggi riecheggia nelle strade infiammate di rivolte di Minneapolis e di tutta l’America. Sono le ultime, disperate parole di George Floyd.
A Minneapolis convivono sentimenti contrastanti. Ci sono la Guardia Nazionale e il governatore Tim Walz che affermano che la situazione sia sotto controllo. I bar chiusi e il centro deserto rispecchiano la paura di nuovi attacchi dei manifestanti e del Coronavirus, che non dà tregua alla regione (600 nuovi casi in Minnesota). Le TV trasmetto nuove immagini che inchiodano Chauvin. Le proteste non si placano: Minneapolis è ancora sotto assedio.
Le voci dei cittadini
In tutto questo caos i cittadini provano a dire la loro, ad instaurare un dialogo con altri cittadini per dare un ordine alla brutalità a cui hanno assistito. All’incrocio tra la Chicago Avenue e la 38esima strada si distingue la voce del pastore Curtis Farar, che ha deciso di tenere la sua predica all’aperto. Il pastore, molto popolare nel suo quartiere, riesce ad interpretare il dolore e la rabbia: le sue parole raccontano tutte e due.
Poco distante si sente parlare di politica. E’ la voce di Rina Morcen, deputata del parlamento del Minnesota e leader del gruppo afro-asiatico, il Caucus. Alla sua voce si aggiunge quella del senatore locale Jeff Hayden. Parlano di giustizia, promettono “la riforma del sistema giudiziario e della polizia”. Il tema è bollente. La promessa era già stata fatta nel 2012 da Janeé Harteau, la prima donna a diventare capo di polizia. Omosessuale e impegnata per limitare la violenza degli agenti. Così si presenta Harteau. La sua dedizione viene però sconfessata nel 2016, quando il poliziotto Jeronimo Yanez uccide l’afroamericano Philando Castile, inerme come Floyd.
Dopo Harteau per volere dei democratici viene messo a capo della polizia l’afroamericano, il primo, Medaria Arrendo. La lotta alla violenza della polizia vive il suo secondo round. Si mette mano ai protocolli: si decide che la “mossa del ginocchio sul collo” può essere usata solo in casi estremi. Però resta nei codici. Di qui la decisione del procuratore Mike Freeman di mandare a giudizio Derek Chauvin con l’accusa di omicidio colposo: il poliziotto avrebbe fatto uso improprio di una tecnica non illegale. Riecheggia tra le macerie ancora fumanti di Minneapolis il richiamo all’impegno per il partito democratico, per il candidato Joe Biden. “Non basta essere contro Trump. Vogliamo mettere mano alle regole, volgiamo la giustizia che nasce da buone regole” dice un cittadino, Joseph Webb IV.
Tra voglia di normalità e paura
A Minneapolis c’è la paura che tutta questa violenza sia stata architettata da qualcuno. Una voce, infondata, parla di un raduno del Ku Klux Klan. Trump apostrofa il gruppo di sinistra radicale ANTIFA come terrorista perché “sta alimentando le rivolte nelle città americane”. Si parla anche di “anarchici venuti da fuori”. L’impressione è che le forze politiche non abbiano la situazione sotto controllo. A contrastare questo senso di caos c’è la voglia di ordine da parte dei cittadini. Molti ragazzi, spesso giovanissimi, si sono adoperati per spazzare via le macerie sulla East Lake Street e hanno distribuito gratuitamente la marce abbandonata del supermercato Target.
C’è voglia di giustizia in America, giustizia finalmente non violenta.